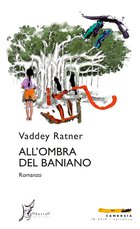A colloquio con Vaddey Ratner
Intervista inedita alla scrittrice cambogiana autrice del romanzo All'ombra del baniano
All’ombra del baniano è un romanzo, basato però da vicino sull’esperienza della sua famiglia in Cambogia durante il genocidio perpetrato dal regime dei khmer rossi fra il 1975 e il 1979. Perché si è decisa a scrivere un romanzo, anziché una memoria?
Quando i khmer rossi presero il potere nel paese, io ero una bambina. Rivisitando quel periodo della nostra vita, mi sono accorta che non potevo essere del tutto certa di ricordarmi negli esatti particolari gli eventi, i luoghi e la cronologia del nostro esodo forzato dalla città alle campagne, le nostre peregrinazioni da un posto all’altro durante quei quattro anni. Avevo cominciato a scrivere il libro come una memoria. Ma mentre filtravo i miei ricordi e ciò che mia madre poteva condividere con me, oltre che i resoconti storici, continuavo a domandarmi più e più volte: Qual è la storia che voglio raccontare? Qual è il mio scopo nel raccontarla? Non è tanto la storia dell’esperienza con i khmer rossi, del genocidio e neppure della perdita e della tragedia. Ciò a cui volevo dare voce era qualcosa di più universale, più significativo, credo, nei termini dell’esperienza umana, e cioè la nostra lotta per aggrapparci alla vita, il nostro desiderio di vivere, anche nelle circostanze più orribili. Nella narrazione di questa vicenda, non era la mia vita che volevo portare all’attenzione degli altri. Io sono sopravvissuta, e il dono della sopravvivenza, mi pare, è già un onore sufficiente. Il mio scopo era di onorare le vite perdute, e io volevo farlo sforzandomi di trasformare la sofferenza in arte.
Non che con questo intenda dire che una memoria non richieda competenza e capacità artistiche. Nel mio caso, data la mia giovanissima età quando i khmer rossi presero il controllo della Cambogia e la scarsità di documenti o fotografie familiari come fonti, potevo affidarmi solo ai miei per lo più traumatici ricordi e alle rievocazioni comprensibilmente riluttanti di mia madre. Per di più, coloro di cui desideravo scrivere, in quanto vittime di sofferenze che sentivo meritevoli di essere conosciute e ricordate più della mia storia, se n’erano andati. Volevo egualmente rievocare le loro parole e i pensieri che avevano condiviso con me. Mi sentivo obbligata a parlare della loro vita, delle loro speranze e dei loro sogni nell’epoca in cui erano ancora vivi. E per farlo bene, mi resi conto che avevo bisogno, non solo di attingere ai ricordi e alla storia, ma anche di usare l’immaginazione, l’arte dell’empatia.
A proposito di arte, qual è stata la sua ispirazione per la scrittura?
Nel campo della scrittura, spesso si parla della voce letteraria come se appartenesse esclusivamente a ognuno di noi come autore o autrice, come se emergesse da una fonte esclusivamente nostra. Più di vent’anni fa, quando ero ancora una liceale, mi capitò tra le mani La notte di Elie Wiesel. Non sapevo che cosa fosse, se una memoria o un romanzo. Penso che non fosse neppure indicato nel libro. Era uno smilzo volumetto, poco più di cento pagine che lessi d’un fiato. E poi ancora e ancora. Era la prima opera di letteratura che leggessi sull’Olocausto, anche se allora non sapevo che cosa significasse la parola. Fu quello scritto che mi spinse a cercare la voce per la mia storia in un’epoca in cui potevo solo comunicare le cose di ogni giorno in una lingua che mi era nuova. Il viaggio di Elie Wiesel attraverso la morte e la disumanità mi commosse al punto che desiderai scrivere, un giorno, un libro che desse voce alla lotta della mia famiglia per la sopravvivenza, per la vita, di fronte a una diversa forma di crudeltà in Cambogia.
Lei aveva cinque anni quando i khmer rossi presero il potere in Cambogia, e la sua protagonista, Raami, ne ha sette. Perché ha deciso di farla più grande di due anni?
In base alla mia esperienza, ho la sensazione di avere cominciato a percepire e capire gran parte di ciò che stava succedendo all’incirca a metà del regime dei khmer rossi, ovvero quando avevo più o meno sette anni, anche se non sono sicura di che età avessi nell’uno o nell’altro momento. Ugualmente, ero consapevole del fatto che stavo crescendo, maturando. Fui costretta a diventare adulta da ciò che sopportavo e vedevo. Nondimeno, c’era una parte di me che voleva disperatamente restare bambina, essere protetta, scappare da tutta la violenza e dalla sofferenza. Cercavo la bellezza ovunque potessi trovarla e mi ci aggrappavo. Così, nella scelta di un’età per Raami, volli che avesse un equilibrio fra introspezione e innocenza. All’inizio del libro è una bambina precoce e curiosa, ma con il procedere della storia diventa più tranquilla e riflessiva, e la sua curiosità si trasforma in una ricerca, un tentativo di capire.
L’esperienza di Raami è molto simile alla sua? Come si differenzia?
L’esperienza di Raami è parallela alla mia. Non c’è prova che lei affronti che io non abbia a mia volta incontrato in un modo o nell’altro. La perdita di diversi familiari, la fame, il lavoro forzato, lo sradicamento e la separazione ripetuti, la sua soverchiante sensazione di essere fondamentalmente sola, ma anche la tenace convinzione che vi sia uno spirito a vegliare su di lei, tutto questo io l’ho sperimentato e sentito. Raami ha avuto la polio da bambina. Anch’io ho avuto la polio quando ero molto piccola. Il nome per esteso di Raami, Vattaaraami, in sanscrito significa “piccolo giardino del tempio”. Il mio nome, in linguaggio vernacolare, allude a qualcosa di simile. Vaddey, o “Watdey”, come si pronuncia in khmer, suona come “terreno di un tempio”. Per questo mio padre scelse quel nome per me.
L’esperienza di Raami diverge dalla mia in particolari minori, le dimensioni della nostra famiglia, il numero di città e villaggi in cui ci mandarono, i nomi di quei luoghi, le date dei vari avvenimenti. Nel libro vi sono innumerevoli piccole variazioni come queste. Come abbiamo già discusso, Raami è di due anni più grande, ma è anche molto più saggia di quanto fossi io. Di certo guarda il mondo con maggiore equanimità di quanto probabilmente facessi io allora o possa fare la maggior parte di noi, anche in età adulta. Eppure, da bambina, ho sempre avuto fiducia nelle persone. Nonostante le atrocità intorno a me, non ho mai mancato di trovare gentilezza e incontrare protezione e tenerezza quando più ne avevo bisogno. Avevo un intuito ben sviluppato riguardo alle persone. Scrivendo All’ombra del baniano, ho dovuto contare su quella comprensione intuitiva, quella capacità di vedere e percepire l’umanità dei singoli in un modo che allargava la mia. Raami condivide la mia fiducia nelle persone. Forse la grande differenza è che lei sa articolarla e, così facendo, ampliarla ancora di più. La sua intuizione diviene prescienza.
I personaggi nel suo romanzo sono basati su membri reali della sua famiglia?
Sì, ma la mia vera famiglia, la schiera di zii, zie e cugini che lasciò la città con noi, era molto più larga. Il romanzo è un universo limitato, sicché ogni personaggio vi si trova per un motivo. Se avessi dovuto comprendere ogni membro della mia famiglia, ne sarebbe venuto un libro elefantiaco! In alcuni casi, ho dovuto combinare diversi membri della mia famiglia per creare un personaggio, o fare altri cambiamenti. Mio padre, per esempio, in realtà era il più giovane di cinque fratelli. Nella storia, invece, ho presentato il padre di Raami come il fratello maggiore in modo da cogliere la serietà di mio padre, il suo ruolo come pilastro della famiglia. Tutti noi guardavamo a lui in cerca di rassicurazione.
Molte scene nel suo romanzo danno vita all’indicibile orrore di quell’epoca nella storia cambogiana. Quali scene ha trovato più difficili da scrivere?
Ogni pagina è stata una lotta. Ho faticato e faticato su ogni singola parola, frase, periodo. Ogni prova che mi aveva spezzato il cuore quando ero bambina me l’ha spezzato di nuovo come adulta intenta a scriverla. C’erano momenti in cui m’inabissavo a una profondità da cui pensavo di non poter più tornare. Ѐ stata una storia dolorosa da rivivere.
Nella Nota dell’autrice lei scrive di suo padre: “Questa storia è nata dal mio desiderio di dare voce alla sua memoria e alla memoria di tutti coloro che sono stati ridotti al silenzio”. Le è riuscito difficile trovare la voce di suo padre dopo tanti anni, o il suo modo di parlare le è venuto naturalmente?
Ho vissuto con la voce di mio padre per tanto tempo. Lui è sempre con me e io ho avuto innumerevoli conversazioni con lui. La sfida non era tanto di tornare indietro nel tempo per trovare la sua voce, ma di attraversare le lingue. Essenzialmente, ho dovuto far parlare mio padre in inglese, e ho dovuto farlo in un modo che non cambiasse il timbro delle sue parole in khmer. Nella nostra lingua, di rado le persone si chiamano per nome, perché è troppo formale o irrispettoso. Per esempio, mio padre mi avrebbe sempre chiamato koan, “bambina”, una parola che in khmer è straordinariamente intima e tenera, ma se il padre di Raami la chiamasse child (bambina) o my child (bambina mia), suonerebbe piuttosto formale e distante, perfino antiquato. Così lui la chiama per nome o semplicemente darling (cara), o con altri vezzeggiativi che mio padre usava con me.
La voce deve adattarsi al personaggio. Io ricordo mio padre come una persona seria, ma mai accigliata. Oltre a vedere la bellezza nel mondo, ne faceva spesso oggetto di riflessione, non di rado ad alta voce per me. Ѐ sempre stato incline alla speranza e piuttosto idealista, come mia madre rileva spesso, ma poiché c’era una punta di tristezza in lui, ho sempre pensato che nella sua persona ci fosse un che di poetico. Benché non fosse un poeta, era un avido lettore di poesia, specialmente dei poemi epici khmer come il Reamker e il Mak Thoeung. Amava le parole ed era lui stesso un infaticabile tessitore di storie. Volevo cogliere le sue qualità essenziali e trasmetterle al padre di Raami. Da un certo punto di vista, il fatto che lui dovesse parlare inglese mi ha aiutato a scrivere, ad andare avanti con la storia. Nella scrittura, ci sono stati momenti in cui, ricordando le sue parole esatte come me le aveva dette nella nostra lingua, con la cadenza e la tenerezza della sua voce, crollavo completamente, dopo di che mi ci volevano molti giorni, se non settimane per tornare a scrivere.
La sua famiglia, come quella di Raami, perse ogni cosa. Siete riuscite a salvare qualche effetto personale o qualche oggetto significativo?
Uscendo da quell’esperienza, pensai che avessimo perso tutto. Poi, nel 1993 in America, nel giorno del mio matrimonio, mia madre mi diede una collana di diamanti che aveva ricevuto dalla mia sdechya, la mia nonna, su cui ho basato la Regina Nonna. La collana era un dono di nozze che mia madre aveva ricevuto da suo nonno. Più di recente, come dono di felicitazione per questo libro, mi diede un paio di orecchini con diamanti. Le montature erano nuove, mi disse, ma i diamanti erano suoi, da prima della guerra.
Ho anche questa minuscola fotografia formato tessera di mio padre di quando era giovane. Mia madre l’aveva staccata dalla carta di identità dopo che l’avevano portato via. Temendo che ci collegasse a lui, buttò il documento, ma tenne la fotografia. Anni dopo negli Stati Uniti notai che il suo nome, A. Sisowath, era inciso sul lato destro. Fu una scoperta toccante perché in quegli anni, in America, era il solo legame tangibile che avevo con lui, a parte mia madre. Nessun’altra persona di mia conoscenza sapeva della sua esistenza. Guardando ora la fotografia, mi sembra di vedere un disagio nella sua posa, – l’inclinazione asimmetrica delle spalle, l’arco interrogativo del sopracciglio sinistro, il sorriso esitante –, come se non si sentisse naturale in quel tentativo di permanenza. L’immagino mentre entra nella stanza, affrontando l’apparecchio con un certo scetticismo, lo spirito in costante movimento, sempre in volo.
Lei e sua madre fuggiste in un campo profughi in Thailandia esattamente come Raami e sua madre? Come siete finite negli Stati Uniti?
La nostra fuga dalla Cambogia fu ancora più contrastata e tortuosa. A un certo punto, lungo una strada abbandonata, fummo di nuovo catturate dai soldati rivoluzionari in fuga davanti all’invasione delle truppe vietnamite. I khmer rossi ci portarono da un villaggio all’altro, poi nella foresta e ancora più all’interno nella giungla. Pensavamo che fosse la fine, che ci avrebbero uccise lì. Quello che vidi, quello a cui assistetti solo in quel viaggio è sufficiente per un altro romanzo.
Nel 1981, lei arrivò negli Stati Uniti come una profuga digiuna di inglese, ma giunse a diplomarsi al liceo con il massimo dei voti nel 1990 e a laurearsi con lode alla Cornell University nel 1995. Com’è riuscita, dopo avere assistito a tutte le terribili atrocità in Cambogia, non solo ad andare avanti, ma anche a svilupparsi e affermarsi?
Quando lasciai la Cambogia, le immagini che mi erano rimaste dentro, che avevano sopraffatto la mia mente, erano immagini di cadaveri... cadaveri e mosche. Poi, atterrando all’aeroporto in California, fui colpita da tutto quel vetro e quell’acciaio scintillanti, non una sola mosca da nessuna parte! Tutto e tutti fervevano di energia. Perfino i nastri dei bagagli ruotavano con magica vitalità. Ero così lontana dalla morte. Il mondo non ci aveva dimenticate, ma neppure ci aveva aspettate. Era andato avanti, aveva prosperato. Mi sentii così fortunata di farne parte. Avevo una tale smania... una tale fame di imparare, e quella fame sopraffece tutto il resto. Assorbii tutto ciò che questo Paese aveva da offrirmi. Qualunque prova mi sia trovata ad affrontare in America, non era nulla in confronto a quelle in Cambogia. Ci hanno dato tanto. Come potevo non riuscire? Ci credevo, e ci credo ancora adesso.
Lei cominciò a imparare l’inglese solo a 11 anni, all’arrivo negli Stati Uniti. Come imparò a scriverlo? Che cosa ha significato rievocare la sua storia in una lingua completamente diversa da quella della sua esperienza?
Cominciai a leggere. Ero un’avida lettrice nella mia lingua, e divenni un’avida lettrice in inglese non appena imparai a leggerlo. Divoravo qualunque cosa su cui potessi mettere le mani. Leggevo cose che non capivo veramente. Mi ricordo che Jane Eyre fu il mio primo romanzo per adulti. Ma non leggevo solo letteratura. Mi soffermavo sulle scritte delle bottigliette di shampoo, perduta nella doccia, sorda ai richiami di mia madre, blandita dagli aggettivi, spumoso, rinvigorente, serico... Passavo poi alla lista dei componenti, tutti quei nomi scientifici avevano in sé un suono e un ritmo, quasi come una poesia. Durante le lezioni di chimica, mentre imparavo a decodificare le lettere e i numeri nelle formule, mi imbattei nella parola tetra, un suono familiare che sentii battermi sulla lingua. Poi, d’improvviso, il lampo nella memoria. Tetraciclina. Mi ricordai che era la medicina, gialla e preziosa come l’oro, in nostro possesso durante il periodo in campagna, quando i farmaci erano quasi inesistenti. La lettura mi ha introdotto a un serie infinita di espressioni, dal linguaggio tematico di termini quali “segreti familiari” o “amore combattuto” che si incontrano in un romanzo come Jane Eyre alle minime parole casuali che scuotevano la mia memoria rivelando ricordi sepolti.
Poi, quando si trattò di imparare concretamente a scrivere, lo feci in sostanza da sola, con il mio ritmo posato. A parte un campo estivo di scrittura quando ero al liceo e un corso di scrittura per racconti alla Cornell University, non ho avuto alcuna istruzione formale in questo ambito. Credo, però, che non ci siano migliori maestri dei grandi esempi: classici che affrontano problemi universali e senza tempo o scrittori contemporanei dai molteplici retroterra culturali e linguistici, capaci non solo di scavare in quelle ricerche esistenziali, ma anche di allargare il mio mondo trasportandomi in una geografia completamente nuova di pensieri, sentimenti e convinzioni.
Io intendevo fare qualcosa di simile con questa storia. Non volevo solo tradurre l’esperienza della mia famiglia, un’esperienza cambogiana, per un pubblico straniero; volevo prendere i lettori e trapiantarli nel fertile terreno da cui ero uscita, farli radicare altrove e germogliare in modo che vedessero il mio mondo come se fosse loro. Volevo che vedessero la Cambogia prima che divenisse sinonimo di genocidio, prima che diventasse il luogo dei “campi di sterminio”. Un tempo era un luogo di squisita bellezza, e io tento di mostrarlo, non solo trasferendo i lettori nell’incanto del mondo naturale, ma anche immergendoli nel ritmo dei pensieri e nei sentimenti di un popolo, nella sua letteratura e nella sua arte. Solo quando sapremo che cosa esisteva potremo veramente piangere ciò che è andato perduto.
Così, a mio modo di vedere, la scrittura di All’ombra del baniano non è stata solo una rievocazione. Ѐ stata un atto creativo, un lungo viaggio verso il suo completamento.
Nella Nota dell’autrice lei narra la sua visita alla corte reale della Cambogia nel 2009. Può descriverci quell’esperienza? Come fu il suo ritorno dopo tanti anni?
Ancora prima della mia visita al palazzo reale, avevo visitato la Cambogia infinite volte, sempre in cerca di mio padre. Ogni volta, l’ho visto in tutto ciò che è andato perduto e in tutto ciò che è stato trovato. Il mio primo viaggio fu nel 1992. Andai dov’era la casa della nostra famiglia a Phnom Penh. La casa non c’era più. Tutto era sparito, salvo una colonna carbonizzata del padiglione del bagno. Ma benché la mia casa fosse sparita, tornai in luoghi che ricordavo di avere frequentato con mio padre, la passeggiata lungo il fiume, le fontane con i loti vicino al Monumento all’Indipendenza, i templi nella città... Durante un viaggio di diversi anni dopo, visitai il palazzo reale, limitandomi ai terreni aperti ai turisti, e m’imbattei in una statua dorata che mi lasciò senza fiato. Era la statua di un uomo a cavallo con una spada nella mano levata. Che fierezza! Mi ricordavo di quella statua. Per molto tempo avevo pensato che si trovasse nel nostro giardino e che ritraesse mio padre. Ma poi scoprii che era la statua di un re! Quando dissi a mia madre del mio stupore per quell’incontro e della confusione nella mia memoria, lei mi diede una spiegazione molto semplice: io avevo spesso accompagnato mio padre al palazzo reale, e la sede della statua con i bei giardini intorno era il luogo dove fuggivamo dall’ufficialità di una cerimonia o di una funzione nelle sale della corte. Là, vicino alla statua, mio padre mi raccontava favole e storie, approfittando di quell’ambiente prezioso per lanciarsi in mitiche avventure. Nel mio ricordo, immagino, mio padre e la statua si erano fusi in una sola entità.
Dal 2005 al 2009, quando tornai con mio marito e mia figlia a vivere a Phnom Penh, molte cose mi divennero chiare. In particolare, vidi di persona la potenza del monsone, la rapidità con cui le piogge potevano allagare la terra in un solo giorno; i diversi modi in cui il riso viene coltivato e raccolto nelle stagioni; la lotta monumentale delle creature minuscole contro gli elementi. Passavo ore con la mia bambina a guardare uno scarabeo stercorario in lotta per uscire dagli escrementi di una mucca! Era un’epifania. Vivere laggiù, anche se a volte mi riusciva difficile per la vicinanza del passato, mi ha straordinariamente aiutato a scrivere All’ombra del baniano.
Alla fine del 2009, poco prima di tornare a vivere negli Stati Uniti, fui invitata a un’udienza con Sua Maestà Re Norodom Sihamoni, in cui dovevo essere formalmente reintrodotta nella famiglia reale. In realtà non volevo andare. Fui presa dal panico. Che cosa avrei portato in dono al re? Di certo, bisognava portare un dono. Ma che cosa poteva mai desiderare Sua Maestà? Cioccolato? Improbabile. Telefonai a mia madre e lei disse che dovevo pensare a un dono che onorasse il nome di mio padre, il suo spirito. Così portai tre tonnellate di riso per i poveri, come contributo allo sforzo umanitario di Sua Maestà. A palazzo, davanti a Sua Maestà, riuscii a malapena a parlare. Riuscivo a pensare solo a mio padre, al suo sacrificio perché fosse possibile quel momento in cui prendevo il suo posto. Non potevo fare a meno di riflettere, tuttavia, che lui non poteva avere la certezza assoluta della mia sopravvivenza. Poteva solo sperare, e io sentivo quella speranza in gola. Quando l’inghiottii, le lacrime mi affluirono agli occhi. L’anno dopo, quando ebbi un’altra udienza con il re, ero molto più preparata e composta.
Come All’ombra del baniano chiarisce, una delle principali strategie dei khmer rossi era dividere le famiglie. Come mantiene, oggi, il contatto con i membri della sua famiglia, compresi quelli che vivono solo nel suo ricordo?
Attualmente, in Cambogia ho uno zio, uno dei due fratelli maggiori di mio padre, ovvero il figlio di mezzo. Ogni volta che lo vedo sono presa dalla disperazione. Piango la sua personalità perduta. Una volta, mentre andavamo a pranzo in automobile, cominciò improvvisamente ad agitarsi. Lui mi spiegò che non era abituato ad andare in automobile ed era completamente disorientato. Una volta le automobili erano una sua passione. Ora, che non è più un principe, vive una vita modesta, conservando il nome preso quando abbandonò la sua identità regale, e si sente più tranquillo quando si trascina a piedi nudi o in un paio di sandaletti per le strade accidentate di Phnom Penh. Ogni volta che lo guardo negli occhi, penso che vi siano piccole morti come queste, in cui alcune parti di noi sono state seppellite con gli altri. Mio zio piange ogni volta che mi vede, come me quando vedo lui o leggo le sue lettere.
Quando tornai a vivere in Cambogia con mio marito e mia figlia, una delle prime cose che feci fu di circondare di fiori la nostra nuova casa. Mi ricordavo la casa della mia infanzia. Riempii il nostro piccolo giardino di orchidee, gelsomini, uccelli del paradiso ed eliconie, oltre a frangipani di diversi colori, anche se, venni a sapere, i cambogiani credono che il fiore attiri i fantasmi. Se così, pensai, era un’offerta quanto mai adatta. Riempii i nostri vasi ogni giorno con steli freschi di loti. Un paio d’anni dopo, comprammo un pezzo di terra a Siem Reap e vi costruimmo una casa, per me un atto terapeutico, un atto concepito contro la distruzione a cui avevo assistito impotente da bambina.
Che cosa pensano i suoi familiari e, in particolare, sua madre della sua decisione di scrivere All’ombra del baniano?
I miei familiari mi sono molto vicini. Mi hanno visto perseverare per tanto tempo con questo libro. Mi hanno vista, non solo tormentata dalla mia rievocazione, dalla resa dei conti con il passato, ma anche dalla fatica stessa di scrivere. Sono molto felici che questa sia una storia che adesso posso condividere con il mondo.
Quanto a mia madre, è molto orgogliosa. Non avrei potuto scrivere questo libro senza la sua benedizione e, naturalmente, la sua condivisione di molti ricordi dolorosi. Alcune storie sui nostri familiari che lei mi raccontava hanno trovato posto in questa narrazione. Siamo passate attraverso tutto quanto insieme. Questo libro è anche suo.
Un tema importante del suo romanzo è il potere delle storie. Che cosa spera che i lettori ricaveranno dalla sua narrazione?
Ho sempre amato le storie, la parola scritta. Già da piccola ne sentivo l’intrinseco potere. Come Raami, vedevo e capivo il mondo attraverso le storie. In Cambogia, sotto i khmer rossi, quando mi trovai sperduta in una foresta o quando venivo abbandonata dalla mia unità di lavoro nella vastità delle risaie perché mi muovevo troppo adagio, ricordavo le leggende che mio padre o la mia bambinaia mi avevano raccontato o le favole che ero riuscita a leggere da me. Le invocavo come incantesimi, intonando ad alta voce le descrizioni e i dialoghi che ricordavo a memoria, in modo da scacciare la paura di trovarmi sola in un luogo deserto, nel silenzio intorno a me. Le storie erano formule magiche per me e la narrazione, la capacità di raccontare e ricordare qualcosa era una sorta di stregoneria, un potere che potevi usare per trasformare e trasportare te stessa. Ancora adesso lo penso e credo che traspaia nella fattura di questo libro per come l’ho scritto. Ma spero che la storia abbia abbastanza strati perché ogni lettore vi trovi l’ispirazione o il messaggio che cerca.